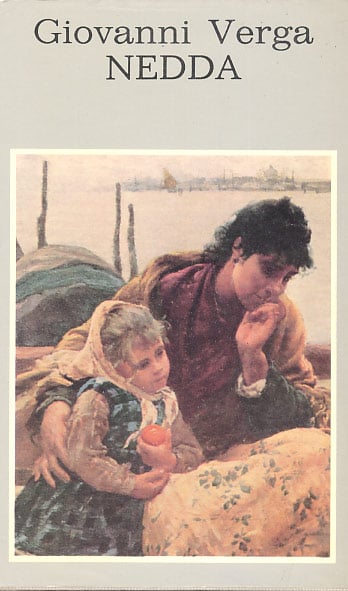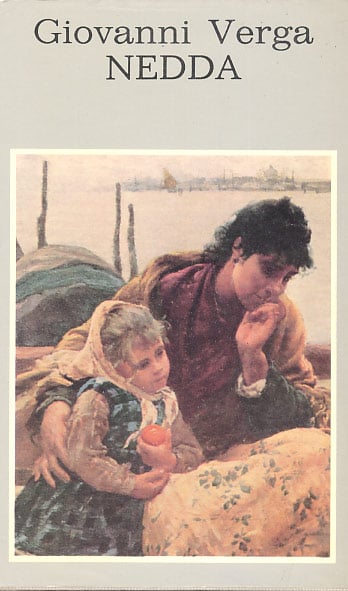Il focolare domestico era sempre ai miei occhi una figura rettorica,
buona per incorniciarvi gli affetti più miti e sereni, come il raggio di
luna per baciare le chiome bionde; ma sorridevo allorquando sentivo
dirmi che il fuoco del camino è quasi un amico. Sembravami in verità un
amico troppo necessario, a volte uggioso e dispotico, che a poco a poco
avrebbe voluto prendervi per le mani o per i piedi, e tirarvi dentro il
suo antro affumicato, per baciarvi alla maniera di Giuda. Non conoscevo
il passatempo di stuzzicare la legna, nè la voluttà di sentirsi inondare
dal riverbero della fiamma; non comprendevo il linguaggio del cepperello
che scoppietta dispettoso, o brontola fiammeggiando; non avevo l’occhio
assuefatto ai bizzarri disegni delle scintille correnti come lucciole
sui tizzoni anneriti, alle fantastiche figure che assume la legna
carbonizzandosi, alle mille gradazioni di chiaroscuro della fiamma
azzurra e rossa che lambisce quasi timida, accarezza graziosamente, per
divampare con sfacciata petulanza. Quando mi fui iniziato ai misteri
delle molle e del soffietto, m’innamorai con trasporto della voluttuosa
pigrizia del caminetto. Io lascio il mio corpo su quella poltroncina,
accanto al fuoco, come vi lascierei un abito, abbandonando alla fiamma
la cura di far circolare più caldo il mio sangue e di far battere più
rapido il mio cuore; e incaricando le faville fuggenti, che folleggiano
come farfalle innamorate, di farmi tenere gli occhi aperti, e di far
errare capricciosamente del pari i miei pensieri. Cotesto spettacolo del
proprio pensiero che svolazza vagabondo intorno a voi, che vi lascia per
correre lontano, e per gettarvi a vostra insaputa quasi dei soffi di
dolce e d’amaro in cuore, ha attrattive indefinibili. Col sigaro
semispento, cogli occhi socchiusi, le molle fuggendovi dalle dita
allentate, vedete l’altra parte di voi andar lontano, percorrere
vertiginose distanze: vi par di sentirvi passar per i nervi correnti di
atmosfere sconosciute: provate, sorridendo, senza muovere un dito o fare
un passo, l’effetto di mille sensazioni che farebbero incanutire i
vostri capelli, e solcherebbero di rughe la vostra fronte.
E in una di coteste peregrinazioni vagabonde dello spirito, la fiamma
che scoppiettava, troppo vicina forse, mi fece rivedere un’altra fiamma
gigantesca che avevo visto ardere nell’immenso focolare della fattoria
del Pino, alle falde dell’Etna. Pioveva, e il vento urlava incollerito;
le venti o trenta donne che raccoglievano le olive del podere, facevano
fumare le loro vesti bagnate dalla pioggia dinanzi al fuoco; le allegre,
quelle che avevano dei soldi in tasca, o quelle che erano innamorate,
cantavano; gli altri ciarlavano della raccolta delle olive, che era
stata cattiva, dei matrimoni della parrocchia, o della pioggia che
rubava loro il pane di bocca: la vecchia castalda filava, tanto perchè
la lucerna appesa alla cappa del focolare non ardesse per nulla; il
grosso cane color di lupo allungava il muso sulle zampe verso il fuoco,
rizzando le orecchie ad ogni diverso ululato del vento. Poi, nel tempo
che cuocevasi la minestra, il pecoraio si mise a suonare certa arietta
montanina che pizzicava le gambe, e le ragazze incominciarono a saltare
sull’ammattonato sconnesso della vasta cucina affumicata, mentre il cane
brontolava per paura che gli pestassero la coda. I cenci svolazzavano
allegramente, e le fave ballavano anch’esse nella pentola, borbottando
in mezzo alla schiuma che faceva sbuffare la fiamma. Quando le ragazze
furono stanche, venne la volta delle canzonette: — Nedda! Nedda la
varannisa! sclamarono parecchie. — Dove s’è cacciata la varannisa?
— Son qua: rispose una voce breve dall’angolo più buio, dove s’era
accoccolata una ragazza su di un fascio di legna.
— O che fai tu costà?
— Nulla.
— Perchè non hai ballato?
— Perchè son stanca.
— Cantaci una delle tue belle canzonette.
— No, non voglio cantare.
— Che hai?
— Nulla.
— Ha la mamma che sta per morire, rispose una delle sue compagne, come
se avesse detto che aveva male ai denti.
La ragazza che teneva il mento sui ginocchi alzò su quella che aveva
parlato certi occhioni neri, scintillanti, ma asciutti, quasi
impassibili, e tornò a chinarli, senza aprir bocca, sui suoi piedi nudi.
Allora due o tre si volsero verso di lei, mentre le altre si sbandavano
ciarlando tutte in una volta come gazze che festeggiano il lauto
pascolo, e le dissero:
— O allora perchè hai lasciato tua madre?
— Per trovar del lavoro,
— Di dove sei?
— Di Viagrande, ma sto a Ravanusa.
Una delle spiritose, la figlioccia del castaldo, che doveva sposare il
terzo figlio di Massaro Jacopo a Pasqua, e aveva una bella crocetta
d’oro al collo, le disse volgendole le spalle: — Eh! non è lontano! la
cattiva nuova dovrebbe recartela proprio l’uccello.
Nedda le lanciò dietro un’occhiata simile a quella che il cane
accovacciato dinanzi al fuoco lanciava agli zoccoli che minacciavano la
sua coda.
— No! lo zio Giovanni sarebbe venuto a chiamarmi! esclamò come
rispondendo a se stessa.
— Chi è lo zio Giovanni?
— È lo zio Giovanni di Ravanusa; lo chiamano tutti così.
— Bisognava farsi imprestare qualche cosa dallo zio Giovanni, e non
lasciare tua madre, disse un’altra.
— Lo zio Giovanni non è ricco, e gli dobbiamo diggià dieci lire! E il
medico? e le medicine? e il pane di ogni giorno? Ah! si fa presto a
dire! — aggiunse Nedda scrollando la testa, e lasciando trapelare per la
prima volta un’intonazione più dolente nella voce rude e quasi
selvaggia: — ma a veder tramontare il sole dall’uscio, pensando che non
c’è pane nell’armadio, nè olio nella lucerna, nè lavoro per l’indomani,
la è una cosa assai amara, quando si ha una povera vecchia inferma, là
su quel lettuccio!
E scuoteva sempre il capo dopo aver taciuto, senza guardar nessuno, con
occhi aridi, asciutti che tradivano tale inconscio dolore, quale gli
occhi più abituati alle lagrime non saprebbero esprimere.
— Le vostre scodelle, ragazze! gridò la castalda scoperchiando la
pentola in aria trionfale.
Tutte si affollarono attorno al focolare ove la castalda distribuiva con
paziente parsimonia le mestolate di fave. Nedda aspettava ultima, colla
sua scodelletta sotto il braccio. Finalmente ci fu posto anche per lei,
e la fiamma l’illuminò tutta.
Era una ragazza bruna, vestita miseramente; aveva quell'attitudine
timida e ruvida che danno la miseria e l’isolamento. Forse sarebbe stata
bella, se gli stenti e le fatiche non ne avessero alterato profondamente
non solo le sembianze gentili della donna, ma direi anche la forma
umana. I suoi capelli erano neri, folti, arruffati, appena annodati con
dello spago; aveva denti bianchi come avorio, e una certa grossolana
avvenenza di lineamenti che rendeva attraente il suo sorriso. Gli occhi
avea neri, grandi, nuotanti in un fluido azzurrino, quali li avrebbe
invidiati una regina a quella povera figliuola raggomitolata sull'ultimo
gradino della scala umana, se non fossero stati offuscati dall'ombrosa
timidezza della miseria o non fossero sembrati stupidi per una triste e
continua rassegnazione. Le sue membra schiacciate da pesi enormi, o
sviluppate violentemente da sforzi penosi, erano diventate grossolane,
senza esser robuste. Ella faceva da manovale, quando non aveva da
trasportare sassi nei terreni che si andavano dissodando, o portava dei
carichi in città per conto altrui, o faceva di quegli altri lavori più
duri che da quelle parti stimansi inferiori al còmpito dell’uomo. La
vendemmia, la messe, la raccolta delle ulive, per lei erano delle feste,
dei giorni di baldoria, un passatempo, anziché una fatica. È vero bensì
che fruttavano appena la metà di una buona giornata estiva da manovale,
la quale dava 13 bravi soldi! I cenci sovrapposti in forma di vesti
rendevano grottesca quella che avrebbe dovuto essere la delicata
bellezza muliebre. L’immaginazione più vivace non avrebbe potuto
figurarsi che quelle mani costrette ad un’aspra fatica di tutti i
giorni, a raspar fra il gelo, o la terra bruciante, o i rovi e i
crepacci, che quei piedi abituati ad andar nudi nella neve e sulle rocce
infuocate dal sole, a lacerarsi sulle spine, o ad indurirsi sui sassi,
avrebbero potuto esser belli. Nessuno avrebbe potuto dire quanti anni
avesse cotesta creatura umana; la miseria l’aveva schiacciata da bambina
con tutti gli stenti che deformano e induriscono il corpo, l’anima e
l’intelligenza — così era stato di sua madre, così di sua nonna, così
sarebbe stato di sua figlia — e dei suoi fratelli in Eva bastava che le
rimanesse quel tanto che occorreva per comprenderne gli ordini, e per
prestar loro i più umili, i più duri servigi.
Nedda sporse la sua scodella, e la castalda ci versò quello che rimaneva
di fave nella pentola, e non era molto.
— Perchè vieni sempre l’ultima? Non sai che gli ultimi hanno quel che
avanza? le disse a mo’ di compenso la castalda.
La povera ragazza chinò gli occhi sulla broda nera che fumava nella sua
scodella, come se meritasse il rimprovero, e andò pian pianino perché il
contenuto non si versasse.
— Io te ne darei volentieri della mia, disse a Nedda una delle sue
compagne che aveva miglior cuore; ma se domani continuasse a piovere....
davvero!... oltre a perdere la mia giornata non vorrei anche mangiare
tutto il mio pane.
— Io non ho questo timore! rispose Nedda con un triste sorriso.
— Perché?
— Perché non ho pane di mio. Quel po’ che ci avevo, insieme a quei pochi
quattrini li ho lasciati alla mamma.
— E vivi della sola minestra?
— Sì, ci sono avvezza; rispose Nedda semplicemente.
— Maledetto tempaccio, che ci ruba la nostra giornata! imprecò un’altra.
— To’, prendi dalla mia scodella.
— Non ho più fame; rispose la varannisa ruvidamente, a mo’ di
ringraziamento.
— Tu che bestemmi la pioggia del buon Dio, non mangi forse del pane
anche tu! disse la castalda a colei che aveva imprecato contro il
cattivo tempo. E non sai che pioggia d’autunno vuol dire buon anno!
Un mormorio generale approvò quelle parole.
— Sì; ma intanto son tre buone mezze giornate che vostro marito toglierà
dal conto della settimana!
Altro mormorio d’approvazione.
— Hai forse lavorato in queste tre mezze giornate perché ti s’abbiano a
pagare? rispose trionfalmente la vecchia.
— È vero! è vero! risposero le altre, con quel sentimento istintivo di
giustizia che c’è nelle masse, anche quando questa giustizia danneggia
gli individui.
La castalda intuonò il rosario, le avemarie si seguirono col loro
monotono brontolio, accompagnate da qualche sbadiglio. Dopo le litanie
si pregò per i vivi e per i morti; allora gli occhi della povera Nedda
si riempirono di lagrime, e dimenticò di rispondere amen.
— Che modo è cotesto di non rispondere amen! le disse la vecchia in
tuono severo.
— Pensava alla mia povera mamma che è tanto lontana: balbettò Nedda
timidamente.
Poi la castalda diede la santa notte, prese la lucerna e andò via. Qua e
là, per la cucina o attorno al fuoco, s’improvvisarono i giacigli in
forme pittoresche; le ultime fiamme gettarono vacillanti chiaroscuri sui
gruppi e su gli atteggiamenti diversi. Era una buona fattoria quella, e
il padrone non risparmiava, come tant’altri, fave per la minestra, nè
legna pel focolare, nè strame pei giacigli. Le donne dormivano in
cucina, e gli uomini nel fienile. Dove poi il padrone è avaro, o la
fattoria è piccola, uomini e donne dormono alla rinfusa, come meglio
possono, nella stalla, o altrove, sulla paglia o su pochi cenci, i
figliuoli accanto ai genitori, e quando il genitore è ricco, e ha una
coperta di suo, la distende sulla sua famigliuola; chi ha freddo si
addossa al vicino, o mette i piedi nella cenere calda, o si copre di
paglia, s’ingegna come può; dopo un giorno di fatica, e per ricominciare
un altro giorno di fatica, il sonno è profondo, al pari di un despota
benefico, e la moralità del padrone non è permalosa che per negare il
lavoro alla ragazza la quale, essendo prossima a divenir madre, non
potesse compiere le sue dieci ore di fatica.
Prima di giorno le più mattiniere erano uscite per vedere che tempo
facesse, e l’uscio che sbatteva ad ogni momento sugli stipiti, spingeva
turbini di pioggia e di vento freddissimo su quelli che intirizziti
dormivano ancora. Ai primi albori il castaldo era venuto a spalancare
l’uscio, per svegliare i pigri, giacchè non è giusto defraudare il
padrone di un minuto della giornata lunga dieci ore, che gli paga il suo
bravo tari, e qualche volta anche tre carlini (sessantacinque
centesimi!) oltre la minestra.
Piove! era la parola uggiosa che correva su tutte le bocche, con accento
di malumore. La Nedda, appoggiata all’uscio, guardava tristemente i
grossi nuvoloni color di piombo che gettavano su di lei le livide tinte
del crepuscolo. La giornata era fredda e nebbiosa; le foglie avvizzite
si staccavano strisciando lungo i rami, e svolazzavano alquanto prima di
andare a cadere sulla terra fangosa, e il rigagnolo s’impantanava in una
pozzanghera dove s’avvoltolavano voluttuosamente dei maiali: le vacche
mostravano il muso nero attraverso il cancello che chiudeva la stalla, e
guardavano la pioggia che cadeva con occhio malinconico; i passeri,
rannicchiati sotto le tegole della gronda, pigolavano in tono piagnoloso.
— Ecco un’altra giornata andata a male! mormorò una delle ragazze,
addentando un grosso pan nero.
— Le nuvole si distaccano dal mare laggiù, disse Nedda stendendo il
braccio; verso il mezzogiorno forse il tempo cambierà.
— Però quel birbo del fattore non ci pagherà che un terzo della
giornata!
— Sarà tanto di guadagnato.
— Sì, ma il nostro pane che mangiamo a tradimento?
— E il danno che avrà il padrone delle olive che andranno a male, e di
quelle che si perderanno fra la mota?
— È vero! disse un’altra.
— Ma pròvati ad andare a raccogliere una sola di quelle ulive che
andranno perdute fra mezz’ora, per accompagnarla al tuo pane asciutto, e
vedrai quel che ti darà di giunta il fattore.
— È giusto, perchè le ulive non sono nostre!
— Ma non sono nemmeno della terra che se le mangia!
— La terra è del padrone to’! replicò Nedda trionfante di logica, con
certi occhi espressivi.
— È vero anche questo; rispose un’altra la quale non sapeva che
rispondere.
— Quanto a me preferirei che continuasse a piovere tutto il giorno
piuttosto che stare una mezza giornata carponi in mezzo al fango, con
questo tempaccio, per tre o quattro soldi.
— A te non ti fanno nulla tre o quattro soldi, non ti fanno! esclamò
Nedda tristamente.
La sera del sabato, quando fu l’ora di aggiustare il conto della
settimana, dinanzi alla tavola del fattore, tutta carica di cartacce e
di bei gruzzoletti di soldi, gli uomini più turbolenti furono pagati i
primi, poscia le più rissose delle donne, in ultimo, e peggio, le timide
e le deboli. Quando il fattore le ebbe fatto il suo conto, Nedda venne a
sapere che, detratte le due giornate e mezza di riposo forzato, restava
ad avere quaranta soldi.
La povera ragazza non osò aprir bocca. Solo le si riempirono gli occhi
di lagrime.
— E laméntati per giunta, piagnucolona! gridò il fattore, il quale
gridava sempre da fattore coscienzioso che difende i soldi del padrone.
Dopo che ti pago come le altre, e sì che sei più povera e più piccola
delle altre! e ti pago la tua giornata come nessun proprietario ne paga
una simile in tutto il territorio di Pedara, Nicolosi e Trecastagne! Tre
carlini, oltre la minestra!
— Io non mi lamento! disse timidamente Nedda intascando quei pochi soldi
che il fattore, ad aumentare il valore, avea conteggiato per grani. La
colpa è del tempo che è stato cattivo e mi ha tolto quasi la metà di
quel che avrei potuto buscarmi.
— Pigliatela col Signore! disse il fattore ruvidamente.
— Oh, non col Signore! ma con me che son tanto povera.
— Pagagli intiera la sua settimana a quella povera ragazza; disse al
fattore il figliuolo del padrone, il quale assisteva alla raccolta delle
ulive. Non sono che pochi soldi di differenza.
— Non devo darle che quel ch'è giusto!
— Ma se te lo dico io!
— Tutti i proprietari del vicinato farebbero la guerra a voi e a me se
facessimo delle novità.
— Hai ragione! rispose il figliuolo del padrone, il quale era un ricco
proprietario e aveva molti vicini.
Nedda raccolse quei pochi cenci che erano suoi, e disse addio alle
compagne.
— Vai a Ravanusa a quest’ora? dissero alcune.
— La mamma sta male!
— Non hai paura?
— Sì, ho paura per questi soldi che ho in tasca; ma la mamma sta male, e
adesso che non son più costretta a star qui a lavorare mi sembra che non
potrei dormire se mi fermassi anche stanotte.
— Vuoi che t’accompagni? le disse in tuono di scherzo il giovane
pecoraio.
— Vado con Dio e con Maria; disse semplicemente la povera ragazza,
prendendo la via dei campi a capo chino.
Il sole era tramontato da qualche tempo e le ombre salivano rapidamente
verso la cima della montagna. Nedda camminava sollecita, e quando le
tenebre si fecero profonde cominciò a cantare come un uccelletto
spaventato. Ogni dieci passi voltavasi indietro, paurosa, e allorché un
sasso, smosso dalla pioggia che era caduta, sdrucciolava dal muricciolo,
o il vento le spruzzava bruscamente addosso a guisa di gragnuola la
pioggia raccolta nelle foglie degli alberi, ella si fermava tutta
tremante, come una capretta sbrancata. Un assiolo la seguiva d’albero in
albero col suo canto lamentoso, ed ella tutta lieta di quella compagnia
gli faceva il richiamo, perché l’uccello non si stancasse di seguirla.
Quando passava dinanzi ad una cappelletta, accanto alla porta di qualche
fattoria, si fermava un istante nella viottola per dire in fretta
un’avemaria, stando all'erta che non le saltasse addosso dal muro di
cinta il cane di guardia che abbaiava furiosamente; poi partiva di passo
più lesto, rivolgendosi due o tre volte a guardare il lumicino che
ardeva in omaggio alla Santa, nello stesso tempo che faceva lume al
fattore, quando doveva tornar tardi dai campi. — Quel lumicino le dava
coraggio, e la faceva pregare per la sua povera mamma. Di tempo in tempo
un pensiero doloroso le stringeva il cuore con una fitta improvvisa, e
allora si metteva a correre, e cantava ad alta voce per stordirsi, o
pensava ai giorni più allegri della vendemmia, o alle sere d’estate,
quando, con la più bella luna del mondo, si tornava a stormi dalla
Piana, dietro la cornamusa che suonava allegramente; ma il suo pensiero
correva sempre là, dinanzi al misero giaciglio della sua inferma.
Inciampò in una scheggia di lava tagliente come un rasoio, e si lacerò
un piede; l’oscurità era sì fitta che alle svolte della viottola la
povera ragazza spesso urtava contro il muro o la siepe, e cominciava a
perder coraggio e a non sapere dove si trovasse. Tutt’a un tratto udì
l’orologio di Punta che suonava le nove, così vicino che i rintocchi
sembravano le cadessero sul capo. Nedda sorrise, quasi un amico l’avesse
chiamata per nome in mezzo ad una folla di stranieri.
Infilò allegramente la via del villaggio, cantando a squarciagola la sua
bella canzone, e tenendo stretti nella mano, dentro la tasca del
grembiule, i suoi quaranta soldi.
Passando dinanzi alla farmacia vide lo speziale ed il notaro tutti
inferraiuolati che giocavano a carte. Alquanto più in là incontrò il
povero matto di Punta, che andava su e giù da un capo all’altro della
via, colle mani nelle tasche del vestito, canticchiando la solita
canzone che l’accompagna da venti anni, nelle notti d’inverno e nei
meriggi della canicola. Quando fu ai primi alberi del diritto viale di
Ravanusa, incontrò un paio di buoi che venivano a passo lento ruminando
tranquillamente.
— Ohè, Nedda! gridò una voce nota.
— Sei tu, Janu?
— Sì, son io, coi buoi del padrone.
— Da dove vieni? domandò Nedda senza fermarsi.
— Vengo dalla Piana. Son passato da casa tua; tua madre t’aspetta.
— Come sta la mamma?
— Al solito.
— Che Dio ti benedica! esclamò la ragazza come se avesse temuto il
peggio, e ricominciò a correre.
— Addio, Nedda! le gridò dietro Janu.
— Addio, balbettò da lontano Nedda.
E le parve che le stelle splendessero come soli, che tutti gli alberi,
noti uno per uno, stendessero i rami sulla sua testa per proteggerla, e
i sassi della via le accarezzassero i piedi indolenziti.
Il domani, ch’era domenica, venne la visita del medico, il quale
concedeva ai suoi malati poveri il giorno che non poteva consacrare ai
suoi poderi. Una triste visita davvero! perchè il buon dottore non era
abituato a far complimenti coi suoi clienti, e nel casolare di Nedda non
c’era anticamera, nè amici di casa ai quali si potesse annunciare il
vero stato dell’inferma.
Nella giornata seguì anche una mesta funzione; venne il curato in
rocchetto, il sagrestano coll’olio santo, e due o tre comari che
borbottavano non so che preci. La campanella del sagrestano squillava
acutamente in mezzo ai campi, e i carrettieri che l’udivano fermavano i
loro muli in mezzo alla strada, e si cavavano il berretto. Quando Nedda
l’udì per la sassosa viottola tirò su la coperta tutta lacera
dell’inferma, perchè non si vedesse che mancavano le lenzuola, e piegò
il suo più bel grembiule bianco sul deschetto zoppo, reso fermo con dei
mattoni. Poi, mentre il prete compiva il suo ufficio, andò ad
inginocchiarsi fuori dell’uscio, balbettando macchinalmente delle preci,
guardando come trasognata quel sasso dinanzi alla soglia su cui la sua
vecchierella soleva scaldarsi al sole di marzo, e ascoltando con
orecchio distratto i consueti rumori delle vicinanze, ed il via vai di
tutta quella gente che andava per i propri affari senza avere angustie
pel capo. Il curato partì, ed il sagrestano indugiò invano sull’uscio
perchè gli facessero la solita limosina pei poveri.
Lo zio Giovanni vide a tarda ora della sera la Nedda che correva sulla
strada di Punta.
— Ohè! dove vai a quest’ora?
— Vado per una medicina che ha ordinato il medico.
Lo zio Giovanni era economo e brontolone.
— Ancora medicine! borbottò, dopo che ha ordinato la medicina dell’olio
santo! già, loro fanno a metà collo speziale, per dissanguare la povera
gente! Fai a mio modo, Nedda, risparmia quei quattrini e vatti a star
colla tua vecchia.
— Chissà che non avesse a giovare! rispose tristemente la ragazza
chinando gli occhi, e affrettò il passo.
Lo zio Giovanni rispose con un brontolio. Poi le gridò dietro:— Ohe! la
varannisa!
— Che volete?
— Anderò io dallo speziale. Farò più presto di te, non dubitare. Intanto
non lascerai sola la povera malata.
Alla ragazza vennero le lagrime agli occhi.
— Che Dio vi benedica! — gli disse, e volle anche mettergli in mano i
denari.
— I denari me li darai poi; — rispose ruvidamente lo zio Giovanni, e si
diede a camminare colle gambe dei suoi vent’anni.
La ragazza tornò indietro e disse alla mamma: — C’è andato lo zio
Giovanni, — e lo disse con voce dolce insolitamente.
La moribonda udì il suono dei soldi che Nedda posava sul deschetto, e la
interrogò cogli occhi.
— Mi ha detto che glieli darò poi; rispose la figlia.
— Che Dio gli paghi la carità! mormorò l’inferma, così resterai senza un
quattrino.
— Oh, mamma!
— Quanto gli dobbiamo allo zio Giovanni?
— Dieci lire. Ma non abbiate paura, mamma! Io lavorerò!
La vecchia la guardò a lungo coll’occhio semispento, e poscia
l’abbracciò senza aprir bocca. Il giorno dopo vennero i becchini, il
sagrestano e le comari. Quando Nedda ebbe acconciato la morta nella
bara, coi suoi migliori abiti, le mise tra le mani un garofano che aveva
fiorito dentro una pentola fessa, e la più bella treccia dei suoi
capelli; diede ai becchini quei pochi soldi che le rimanevano perchè
facessero a modo, e non scuotessero tanto la morta per la viottola
sassosa del cimitero; poi rassettò il lettuccio e la casa, mise in alto,
sullo scaffale, l’ultimo bicchiere di medicina, e andò a sedersi sulla
soglia dell’uscio, guardando il cielo. |